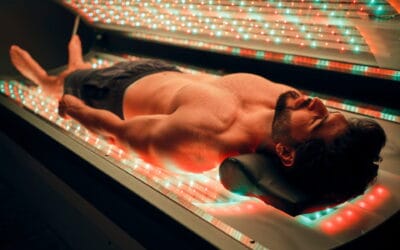Nel tempo il nostro DNA cambia: accumula progressivamente dei piccoli danni, cioè mutazioni (o, meglio, alterazioni), che sono parte del processo di invecchiamento. Quando l’instabilità del genoma (ovvero la frequenza di questi danni al materiale genetico) aumenta, il fenomeno può sottendere allo sviluppo dei tumori e di alcune patologie degenerative. Tanti fattori contribuiscono all’accumulo di danni al DNA e sono sia esogeni, come le sostanze chimiche o le radiazioni ionizzanti, sia endogeni, per esempio i radicali liberiUn radicale libero è una molecola o un atomo particolarmente reattivo che contiene almeno un elettrone spaiato nel suo orbitale più esterno. A causa di questa caratteristica chimica, i radicali liberi sono altamente instabili e cercano di tornare all'equilibrio rubando all'atomo vicino l'elettrone necessario per pareggiare la propria carica elettromagnetica. Questo meccanismo dà origine a nuove molecole instabili, innescando una reazione a catena che, se non viene arrestata in tempo, finisce col danneggiare le strutture cellulari ed i processi metabolici. dell’ossigeno (ROS) o gli errori random nel processo di replicazione del DNA. Fortunatamente, la maggior parte degli organismi viventi, noi compresi, è dotata di meccanismi di riparazione del DNA, che tuttavia invecchiando diventano inefficienti. Lo abbiamo accennato nel primo capitolo ed ora scenderemo più in profondità, per capire meglio gli aspetti biologici che sottendono a questo processo.

Come è fatto il DNA?
Il DNA, o acido desossiribonucleico, è il materiale che raccoglie tutte le informazioni, “impacchettate” in geni, relative a un essere vivente. È come un libro di ricette, ciascuna delle quali serve per creare le proteine che compongono l’organismo e gli consentono di funzionare.
Dal punto di vista chimico il DNA è un polimero, ossia una macromolecola che si compone di quattro differenti monomeri. Ogni monomero, che prende il nome di nucleotide, è costituito da un gruppo fosfato, una molecola di zucchero (desossiribosio) e una base azotata (adenina, timina, citosina o guanina). I monomeri si uniscono tra loro a formare una catena (o filamento) di DNA. In realtà la maggior parte del DNA presente nelle nostre cellule è a doppio filamento: due catene polinucleotidiche si uniscono tra loro per affinità di basi azotate, che formano coppie adenina-timina e guanina-citosina. Possiamo immaginare la molecola di DNA a doppio filamento come una scala a pioli, in cui l’impalcatura è costituita dalle molecole di zucchero e dai gruppi fosfato, mentre i pioli sono le basi azotate. Tale molecola, poi, si avvolge su sé stessa a formare la famosa doppia elica del DNA.
Ogni macromolecola di DNA è composta da due filamenti complementari di nucleotidi che si avvolgono a formare la famosa doppia elica.