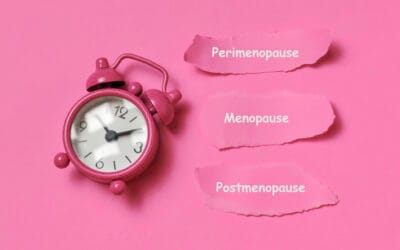Come si misura l’infiammazione?
Come vi abbiamo spiegato in un articolo precedente, l’infiammazione latente (o di basso grado) è silente e molto subdola perché crea le basi per tutte le patologie legate all’invecchiamento. Ma è possibile rilevarla e misurarla? Sì, e ci sono diversi modi per farlo. È importante però ricordare che i biomarcatori utilizzati non sono tutti sensibili e affidabili allo stesso modo.
Innanzitutto va detto che i classici esami utilizzati per rilevare l’infiammazione acuta non servono per captare l’infiammazione cronica. Prendiamo il caso della VES (velocità di eritrosedimentazione), ad esempio. Questo indice, che compare negli esami ematici, indica la velocità con cui la parte corpuscolata del campione di sangue (reso incoagulabile) si sedimenta alla base della provetta. Tale indice aumenta in presenza di patologie infettive e infiammatorie (come l’artrite reumatoide) e non solo (infarto, anemia, tumori…). Quando la VES cambia, però, significa che il danno all’organismo è già presente ed è di solito di grande entità. L’obiettivo di misurare l’infiammazione cronica latente, invece, è quello di poter poi agire in modo da prevenire che tali danni si verifichino.
Serve misurare la Proteina C Reattiva (PCR)?
Un parametro di cui spesso si sente parlare è la Proteina C Reattiva (PCR). Di cosa si tratta? Cominciamo col dire che è una proteina prodotta dal fegato in elevate quantità quando è in corso un’infiammazione, ed è possibile rilevarla con un semplice esame del sangue periferico (di solito, i valori di riferimento della PCR sono inferiori a 5-10 mg/L). Come la VES però, anche l’esame normale della PCR indica un danno già avvenuto e rileva l’infiammazione acuta, mentre è poco sensibile per quella cronica latente. Più indicativo comincia ad essere il test per la proteina C-reattiva ad alta sensibilità. In cardiologia, per esempio, si utilizza per valutare il rischio di eventi cardiovascolari, anche legato all’aterosclerosi.
L’obiettivo di misurare l’infiammazione cronica è quello di poter agire per prevenire le patologie ad essa associate e migliorare lo stato di salute

A cosa serve misurare l’Interleuchina 6?
Per avere misurazioni più precise e affidabili bisogna passare ad un altro tipo di diagnostica, più sofisticata. Un modo è rilevare nel sangue alcune specifiche citochineLe citochine sono proteine di piccole dimensioni prodotte dal sistema immunitario, che si legano a specifici recettori presenti sulla membrana e comunicano alla cellula un'istruzione specifica come, ad esempio, lo stimolo a crescere, oppure a differenziarsi o ancora l'ordine di morire. Vengono prodotte da diversi tipi di cellule e, una volta liberate nell'organismo, inducono specifiche reazioni nelle cellule adiacenti (effetto paracrino), in altre molto lontane (effetto endocrino) oppure in quelle che le hanno create (effetto autocrino). pro-infiammatorie, come l’IL-6 (interleuchina 6), la più citata dalla comunità scientifica. IL-6 viene prodotta da cellule del sistema immunitario ed è un marcatore della sua attivazione, perché aumenta in presenza di infiammazione. Anche in questo caso i suoi livelli spesso sono associati a malattie (autoimmuni, cardiovascolari, tumori) e spesso viene misurata in pazienti con diabete e altri fattori di rischio cardiovascolare. Meno usata nella pratica clinica è la misurazione della Neopterina. Anche questa molecola viene rilasciata da cellule del sistema immunitario (i macrofagi) e indica uno stato immunitario pro-infiammatorio.

Diversi marcatori, tra cui l’IL-6, permettono di valutare lo stato infiammatorio.
Oltre all’IL6 si possono misurare i livelli plasmatici di altre citochine infiammatorie, come il TNF e la IL1-beta. Trattandosi però di misurazioni piuttosto costose, non trovano un utilizzo frequente nella pratica clinica. Da considerare anche la recente introduzione di test che misurano i livelli salivari di queste citochine, per i quali però mancano ancora dati da studi clinici su casistiche importanti.
Dal punto di vista prettamente pratico, il marcatore più accessibile, ad oggi, resta il test della PCR ad alta sensibilità, che ci dice se è presente o meno uno stato infiammatorio
Quali altri marcatori per l’infiammazione di basso grado?
Da qui si sale a un ulteriore livello della diagnostica. Uno dei marcatori emersi di recente dallo studio della genetica dell’invecchiamento è il CXCL9, una citochina che può valutare il rischio di malattie cardiovascolari (ne abbiamo parlato in questo articolo). È un marker importantissimo ma molto poco impiegato nella pratica clinica. Nei grandi studi sui centenari e sulle persone che invecchiano in salute, è stato dimostrato che esistono polimorfismi (cioè varianti che cambiano per una singola lettera) del gene che codifica per CXCL9 associati alla longevità, al punto da essere considerati tra i più importanti marcatori di inflammaging nell’ambito della ricerca. Restando in tema di genetica e polimorfismi, è possibile studiare quelli che codificano, per esempio, per la già citata Interleuchina 6 per l’Interleuchina 10, il TNF e la IL1beta.
Un ultimo livello di analisi per l’infiammazione di basso grado è quello su cui stiamo lavorando a SoLongevity: si basa su modificazioni epigenetiche di alcuni nostri geni. È infatti possibile misurare il livello di metilazione dei geni legati all’infiammazione.
Qual è il metodo ideato da SoLongevity?
Dal punto di vista prettamente pratico, il marcatore più accessibile, ad oggi, resta il test della PCR ad alta sensibilità, che ci dice se è presente o meno uno stato infiammatorio. Ma c’è un ultimo livello di analisi per l’infiammazione di basso grado, che è quello su cui stiamo lavorando a SoLongevity, e che si basa su modificazioni epigenetiche di alcuni nostri geni. È infatti possibile misurare il livello di metilazione (la modificazione epigeneticaLetteralmente “al di sopra della genetica”. Con questo termine s’intendono tutti i processi biochimici che, senza modificare la sequenza del DNA, incidono sulla espressione dei geni, sia “accendendoli” che “spegnendoli”. più importante) dei geni legati all’infiammazione, come i-NOS (Inducible Nitric Oxide Synthase), un gene che viene metilato o demetilato in base al rischio infiammatorio.
Tali miglioramenti possono essere ottenuti, per esempio, con integrazioni nutrizionali specifiche come Cell-Fasting, o con farmaci anti-infiammatori come l’aspirina, o con azioni sul microbioma intestinale e interventi dietetici mirati. Per misurare l’efficacia di questi interventi, la Proteina C Reattiva non è sufficiente: avere a disposizione test e nuovi biomarcatori su cui stiamo lavorando permette invece di ottenere informazioni molto puntuali e utili per migliorare la nostra salute.